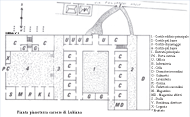Protagonista: Tullio Binaghi
Autore:
Da Schio, Tullio Binaghi, ci invia questa testimonianza.
Si tratta di un’esperienza di carcere (dal 1945 al 1946) in Slovenia.
Il suo racconto è completato da un elenco delle persone che egli ebbe modo di incontrare in quella dolorosa circostanza.
Nella lettera specifica infatti che “essendo uno dei pochi sopravvissuti di quel gruppo, reputo sia mio dovere rendere noto ciò di cui sono a conoscenza”. Ringraziamo il signor Binaghi.
Imprigionato perchè indossavo degli stivali nuovi
La mia vuole essere una testimonianza quanto più concisa possibile, limitata ai fatti di cui sono certo, riguardante in gran parte, persone arrestate a Trieste e Gorizia durante i 45 giorni d’occupazione jugoslava, deportate e in maggioranza mai più tornate.
Le osservazioni personali sono contenute perché mi si potrebbe rimproverare di parzialità, il che sarebbe anche umano; gli allegati (l’elenco delle persone incontrate e la piantina della prigione) sono a supporto di quanto esposto.
Sono stato fermato dagli iugoslavi il 27 giugno 1945 alla stazione di Divaccia dove era in sosta il treno che da Trieste doveva portarmi a Pola.
Provenivo da Venezia dove ero stato ospitato, in qualità di reduce, al convitto Morosini alle Fondamenta Nuove, dalla metà circa del mese di maggio.
In precedenza avevo prestato servizio militare alla Repubblica Sociale Italiana, prima all’ufficio matricola del Distretto Militare di Pola e in seguito, in qualità di soldato semplice, al trentunesimo Deposito Misto Provinciale - compagnia deposito, posta da campo 847 - presso la caserma di Via Rossetti a Trieste.
Alla calata dei Titini, ma non subito, ero riparato a Venezia assieme a Dino Montagner, nativo di Bagnole ( Pola), mio commilitone ed amico.
La mattina del 27 giugno ero salito sul treno alla stazione ferroviaria di Venezia per rientrare in famiglia, ignorando i pericoli che mi accingevo a correre.
Perché venni fermato non lo so.
Forse gli stivali che calzavo insospettirono il milite che mi fece scendere; per il resto ero vestito normalmente, cioè molto male e portavo in spalla uno zaino con pochi effetti personali.
Testimone delmio fermo, Olga Angelini, una lontana parente che durante il periodo bellico abitava a Trieste, in Via Udine.
Trascorsi la notte a Divaccia, sotto chiave.
La mattina dopo, assieme ad altri due, fui spostato sotto scorta, a mezzo treno, a San Pietro del Carso, in quella che era la caserma della milizia.
Ci rimasi un solo giorno perché la notte stessa, su camion scoperto, assieme a molti altri, con le mani legate dietro la schiena con del filo telefonico, fui trasferito a Villa del Nevoso in una vecchia e putrida prigione.
Dopo alcuni giorni mi trasferirono assieme ad altri disgraziati, all’ex caserma dei carabinieri, posta un po’ fuori dello stesso paese, su una strada in leggera salita.
Benché il tragitto fosse breve, tutto si svolse secondo un copione collaudato: buio della notte, camion scoperto, filo di telefono.
L’edificio era utilizzato per schedare i prigionieri ed avere da loro informazioni, in qualsiasi modo, passando dall’intimidazione alla violenza.
Non venni maltrattato, fui fotografato e mi presero le impronte, come fanno tutte le polizie di questo mondo.
Le prigioni erano ricavate negli scantinati della caserma e alle finestre, quasi a livello di terra, erano state fissate delle tavole per impedirci di vedere e di essere visti.
Bisognava parlare sottovoce; si boccheggiava per il caldo, la sete, la scarsissima aerazione.
Qui rimasi fino al 14 luglio; quella notte trasferimento, con il solito sistema, ad Aidussina.
Il carcere di questa località era in parte diroccato per bombardamento o incendio recenti.
Finii in una cella d’angolo, in fondo ad un corridoio parallelo al cortile d’entrata.
Nella stanzetta c’era una persona snella e alta con i capelli brizzolati; parlava discretamente l’italiano, mi disse di chiamarsi Fortkner, era stato berater di Portorose.
In una stanza del piano superiore c’era sua moglie; avevano una bambina piccola ma non sapeva come e dove era stata sistemata.
Il mattino dopo lo trasferirono.
 Language
Language English
English